 Area professionisti | Le schede coltura | La fertilizzazione | Fisica del substrato
Area professionisti | Le schede coltura | La fertilizzazione | Fisica del substrato
La fertilità fisica del terreno colturale è considerata come l'attitudine del terreno stesso a fornire acqua e aria alle radici.
Per saper fertilizzare, è quindi necessario saper gestire nell'ordine:
Questo stesso ordine di determinazione deve essere applicato nella scelta di un supporto di coltura.
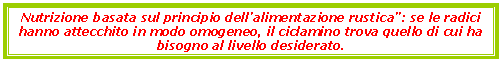
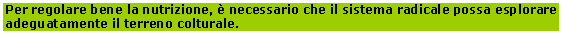
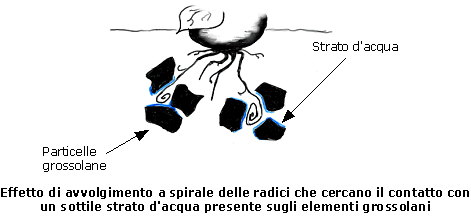
Quando le radici si avvolgono a spirale o si sviluppano in maniera irregolare, riducono due delle loro potenzialità:
Esempio:
Caso di un substrato costituito al 70% da cortecce 15-25 + 30% di torba; la torba è fine.
Se la composizione è irregolare, la proporzione di torba può diventare ben presto insufficiente.
Le radici, allora, vanno in cerca dell'acqua, tentando di ricreare un contatto permanente con il sottile strato d'acqua presente sulle fibre.
A questo punto può subentrare il "danno".
Il terreno colturale, infatti, tende a seccare e ciò rende necessarie annaffiature più frequenti.
Ora, poiché queste radici sviluppatesi in maniera irregolare presentano un basso potere di assorbimento dell'acqua, possono morire o per stress idrico, o per asfissia.
Il terreno colturale, quindi, non è né abbastanza costante, né protettivo.
Esempio tipico di carenza di manganese
La carenza di manganese si manifesta sempre molto velocemente dopo il rinvaso.
Perché? Perché durante gli stadi più giovani della coltivazione il sistema radicale, essendo ancora poco sviluppato, esplora un volume ridotto di substrato o di terreno.
Se il terreno colturale presenta un basso tenore di manganese assimilabile, le quantità di manganese assorbite sono insufficienti e la carenza si manifesta con sintomi visibili.
A pari livello di manganese assimilabile contenuto nel substrato, la carenza non si manifesterà negli stadi adulti grazie alla migliore esplorazione del terreno da parte delle radici.
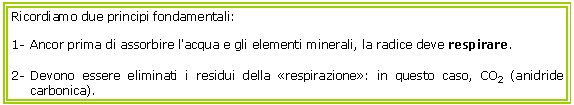
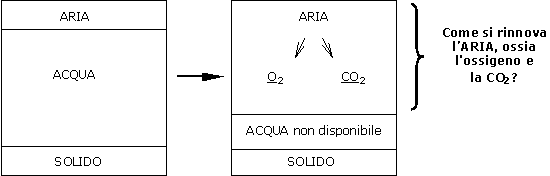
Significa che più il substrato si scalda velocemente, maggiore è la velocità di circolazione dei gas nel substrato e la loro «dissipazione». L'anidride carbonica, quindi, è «espulsa» dalla pressione dell'ossigeno nell'atmosfera ambiente del vaso.
I gas, tra cui l'ossigeno e l'anidride carbonica, sono in parte «disciolti» nell'acqua.
L’acqua, quindi, tramite il suo stesso rinnovamento, può eliminare la carica di CO2.
Più si potranno effettuare annaffiature frequenti e regolari (in base alla scelta del substrato) e più l'effetto «espulsione» sarà rilevante.
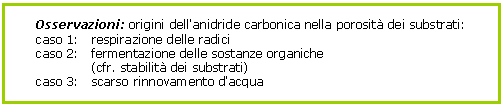
La scelta del substrato dipenderà anche dalla mobilità dell'acqua.
Maggiore è la circolazione d'acqua, migliori potranno essere le funzioni radicali.
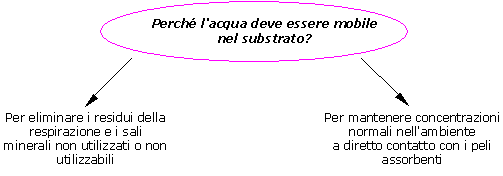
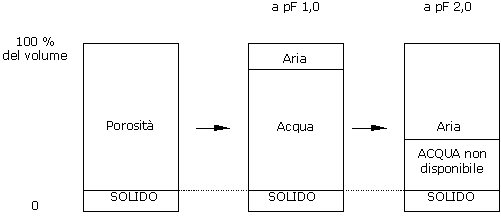
Un substrato deve assolvere contemporaneamente due funzioni:
Il contatto «radici/substrato» è un elemento essenziale per gestire la vigoria della pianta tramite il controllo dello stress idrico.
Infatti, maggiore è il contatto tra la fase solida e la radice, migliore sarà la «protezione» meccanica della radice.
Questa protezione, spesso assicurata da materiali fini colloidali (ad esempio l'argilla o la torba nera), fa aumentare la soglia di resistenza delle radici allo stress idrico.
In tal caso, la protezione «colloidale» delle radici consente di gestire con più facilità la vigoria della pianta.
L'assenza di protezione "colloidale" del bulbo provoca anomalie rilevanti nella crescita della pianta: foglie arricciate per carenza di boro indotta, fioritura irregolare, blocco della vegetazione.
L'utilizzo di materiali pesanti (terra, …) in un substrato, infatti, porta sempre ad una perdita di porosità, e la perdita di porosità avviene sempre a discapito dell'aria (e non dell'acqua...).
Ora, più la produzione di un ciclamino è elevata, maggiore dovrà essere la respirazione,soprattutto a livello delle radici.
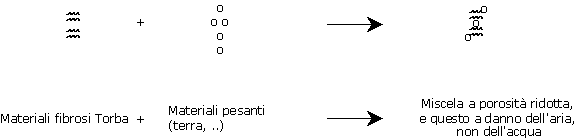
Un substrato occupa, in un dato recipiente, un certo volume. Questo volume è occupato dalla fase solida e dai fluidi: fase liquida e fase gassosa.
I fluidi si trovano nel volume degli «spazi vuoti», meglio noto come porosità.
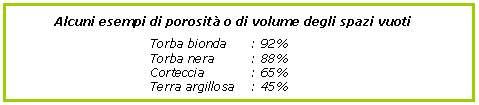
In un vaso da un litro, una torba bionda occupa un volume di un litro. Questo volume è occupato solo per l'8% da fase solida. In un vaso da un litro, ci sono quindi 920 millilitri di «spazi vuoti»!
Ciò spiega l'interesse dei materiali a bassa porosità, in quanto è proprio negli spazi vuoti che circolano l'acqua e l'aria, i due nutrimenti indispensabili alla crescita.
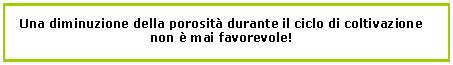
Perché ogni perdita di porosità (e quindi di spazi vuoti) avviene essenzialmente a discapito dell'aria. Poiché le radici devono respirare per «produrre», è chiaro che la produzione sarà maggiore se verranno soddisfatti i fabbisogni respiratori.
Una compattazione al momento del rinvaso può provocare effetti irreversibili.
Questo fenomeno sarà più accentuato nel caso in cui si utilizzi un substrato umido.
Attenzione, quindi, a comprimere meno un substrato più umido del solito.
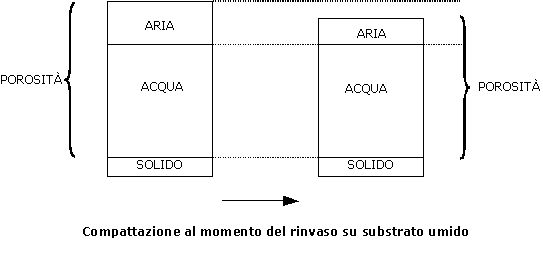
Il fenomeno della perdita di porosità e di fibrosità è spesso compensato, a questo stadio, dallo sviluppo radicale, e quindi risulta meno grave.
Ciò che interessa il ciclamino è il volume d’acqua presente nel contenente.
Rimane poi da definire la disponibilità di quest'acqua per il ciclamino.
L’acqua è disponibile per il ciclamino solo quando la radice è in grado di esercitare una suzione della stessa.
La suzione è un fenomeno di trasferimento dell'acqua attraverso la membrana radicale che si effettua solo quando esiste una differenza di potenziale idrico tra la radice e l'acqua.
Affinché la suzione sia efficace, è quindi necessario che il potenziale idrico del substrato sia sempre maggiore del potenziale idrico della radice.
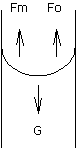
Esempio che illustra la forza della matrice:
Le torbe bionde presentano una fibrosità maggiore rispetto alle torbe nere e una distribuzione regolare dei diametri dei pori, con una maggioranza di pori di diametro superiore ai 30 micron.
La torba nera gelata, dopo la riasciugatura per forza gravitazionale, trattiene una quantità d'acqua spesso equivalente (capacità di trattenere l'acqua a pF 1,0).
Tuttavia, la sua struttura capillare è molto più sottile e la maggior parte dei pori presenta un diametro compreso tra 3 e 30 micron, ossia le loro dimensioni sono molto più piccole rispetto ai pori della torba bionda.
Le forze della «matrice» della torba nera, quindi, sono molto più deboli rispetto a quelle della torba bionda.
Ciò significa che nella torba nera rimane una frazione d'acqua non disponibile, ovvero una parte d'acqua trattenuta con forza nei pori di piccole dimensioni.
Essa deve essere considerata soprattutto come uno strumento di paragone tra diversi substrati.
Lo scopo dell'irrigazione sarà piuttosto mantenere l'umidità del substrato entro due limiti:
Questi valori sono usati nell'analisi ponderale per i sistemi di pesatura e nel valore logaritmico per i tensiometri (pF).
Poiché il sistema radicale del ciclamino ha bisogno di molta aria, è necessario scegliere un substrato che abbia le seguenti caratteristiche:
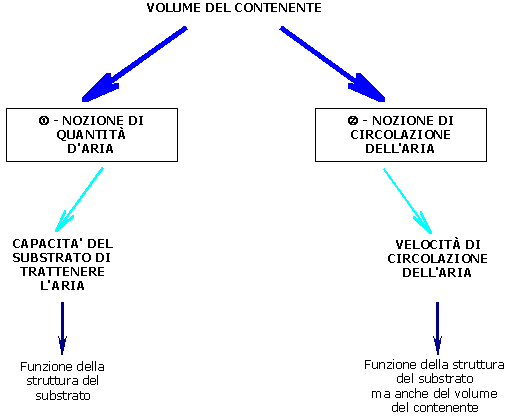
Quando l'acqua abbandona una parte della porosità, è progressivamente sostituita dall'aria.
Questa capacità di trattenere l'aria è caratterizzata dalla curva del pF.
Essa è calcolata con la seguente formula:
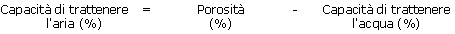
Ad ogni pF corrisponde allora un nuovo valore della capacità di trattenere l'aria.
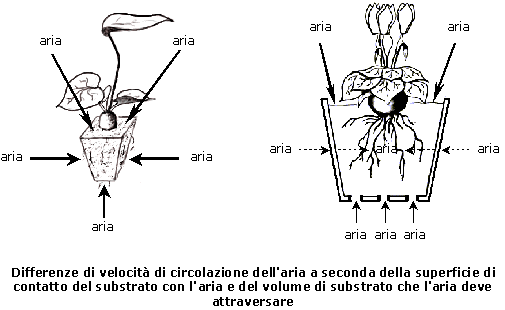
I fattori che condizionano la circolazione dell'aria all'interno di un volume di substrato sono:
1 > la superficie di contatto sviluppata tra l'aria e il volume di substrato;
2 > il volume del contenente da «attraversare».
Esempio:
Nel caso di un pane di terra per la coltivazione di giovani piante di ciclamino, la superficie di contatto tra l'aria e il pane di terra è estesa.
Le radici devono percorrere una brevissima distanza per trovare una pressione dell'ossigeno soddisfacente.
Il substrato, in tal caso, può presentare:
E' il caso del substrato tradizionale ad alto contenuto di torbe nere gelate.
Al contrario, nei vasi con diametro di 14 cm, la superficie di contatto con l'aria è inferiore.
Di conseguenza, la pressione dell'aria all'interno del vaso deve aumentare.
La stessa torba nera utilizzata in vaso diventa asfissiante, perché la disponibilità d'aria nell'insieme del vaso non è sufficiente.
In questo caso bisogna ricorrere a materiali a maggiore aerazione:
Maggiore è il volume del contenente, maggiore deve essere la capacità del substrato di riossigenarsi dopo l'annaffiatura.
Per produrre, le radici devono respirare.
Ma devono anche ricevere una quantità di calore sufficiente.
Se il calore fornito alle radici non è sufficiente, il ciclamino abbassa il suo «coefficiente di respirazione» diminuendo di conseguenza la capacità produttiva.
Maggiore è la velocità di circolazione dell'aria «ambiente» della serra nel substrato, più quest'ultimo si riscalda grazie al «calore» fornito dall'aria.
Al contrario, se il calore fornito dalla circolazione dell'aria è eccessivo, si dovrà scegliere un substrato con buona capacità di raffreddamento, facendo attenzione soprattutto a mantenere una quantità «d'acqua non disponibile» sufficiente.
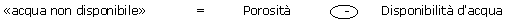
Nella coltivazione in vasi su terreno colturale organico, al di là di pF 2,0 si considera, generalmente, che l'acqua è «non disponibile» per il ciclamino.
Quest'acqua «non disponibile», tuttavia, presenta una caratteristica molto interessante: consente di «diluire» la salinità.
Spesso, infatti, la salinità presa in considerazione è quella misurata in un substrato in condizioni di massima ritenzione idrica.
Ora, quando si vuole «gestire» lo stress idrico, si tendono ad effettuare annaffiature a livello del punto di avvizzimento.
In questo caso, la salinità effettiva a pF 2,0 è da due a quattro volte più alta di quella misurata abitualmente.
Poiché il ciclamino è particolarmente sensibile all'attenzione prestata agli eccessi di salinità, è essenziale scegliere un substrato che abbia una quantità d'acqua NON disponibile sufficiente.
Per gestire lo stress idrico è necessario «proteggere» la radice.
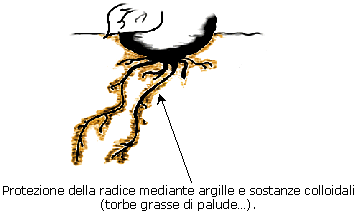
La gestione dello stress idrico è importante per controllare la vigoria della pianta, ma anche nel caso di annaffiature irregolari.
I «colloidi» sono sostanze caricate «negativamente», in grado di stabilire un'affinità con la radice. Quest'ultima, quindi, è protetta dalle argille o dai colloidi organici.
In tal modo, il punto di avvizzimento passa da pF 2.2 a 2.4.
Senza questa protezione, la gestione dello stress idrico risulta rischiosa e la dinamica degli oligoelementi (alluminio, ferro...) può subire riduzioni.
Alcuni substrati contengono materie prime fermentescibili: cortecce, fibre non stabili, compost,...
Fermentazione:
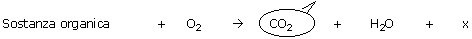
Questi materiali fermentano in presenza di ossigeno e producono quindi CO2(anidride carbonica) nel terreno colturale.
L’anidride carbonica, se non è eliminata regolarmente, soffoca le radici che, di conseguenza, non respirano più a sufficienza.
Le radici asfissiano non per eccesso d'acqua, bensì per saturazione da anidride carbonica.
Inoltre, contrariamente a ciò che si pensa, nelle piante sviluppatesi su substrati fermentescibili, la mancanza di ossigeno è addirittura più importante del fabbisogno di azoto.
Ecco perché è essenziale scegliere materiali con il più elevato grado possibile di stabilità!
Regola n° 1: esaurire sempre la RFU (Riserva Facilmente Utilizzabile) prima di ricorrere all'annaffiatura.
(Quantità d'acqua misurata tra pF 1,0 e pF 1,7).
Le radici possono così soddisfare il proprio fabbisogno di ossigeno ed essere in grado di compensare una mancanza temporanea.
Regola n° 2: evitare un essiccamento eccessivo degli strati superficiali, adiscapito delle qualità fisiche dei substrati: effettuare annaffiature in dosi ridotte, in modo tale che la riumidificazione sia limitata in profondità, alla base del vaso. Questa modalità di annaffiatura va applicata nelle prime settimane successive al rinvaso per favorire la formazione delle radici a fittone.
Regola n° 3: assicurare periodicamente un'annaffiatura lisciviante, in modo darinnovare l'atmosfera del substrato a effetto «espulsione».
Regola n° 4: evitare che l'umidità scenda oltre la RFU (Riserva FacilmenteUtilizzabile) se si desidera ottenere la massima vigoria della pianta, vale a dire foglie grosse e un aspetto voluminoso, a discapito dei fiori.
Regola n° 5: annaffiare solo quando la riserva utile (disponibilità d'acqua tra pF1,0 e pF 2,0) è ormai esaurita per gestire lo stress idrico e mantenere l'equilibrio foglie/fiori. Al contempo, però, non attendere troppo a lungo prima di eseguire le annaffiature, altrimenti si rischia la comparsa precoce di fiori e un incorretto sviluppo del bulbo.
Regola n° 6: regolare la salinità in base alla quantità d'acqua non disponibile (porosità - disponibilità d'acqua), soprattutto nel periodo estivo. Mantenere livelli di conducibilità piuttosto bassi, al fine di evitate attacchi crittogamici.
Regola n° 7: nei periodi interstagionali pensare alle annaffiature «acicliche» piuttosto che alle annaffiature in dosi e cicli regolari, per favorire soprattutto l'assimilazione di elementi come calcio e magnesio.
Regola n° 8: non praticare "l'irrigazione per aspersione" sul ciclamino. Essa, infatti, provoca uno squilibrio vegetativo, una fragilità della pianta e rischi sanitari.
2565, rue de Montourey
83600 Fréjus - France
Telefono internazionale : +33 (0)4 94 19 73 04
Centralino : + 33 (0)4 94 19 73 00
Fax : +33 (0)4 94 19 73 19

